Riassunto
Questo articolo presenta un modello che consente di interpretare le migrazioni, un fenomeno che interessa una grande massa di persone sul pianeta, come un evento traumatico. Vengono descritti i fattori di resilienza e quelli di vulnerabilità che incidono sulla salute psichica dei migranti e in particolare gli effetti che essi hanno sulle popolazioni di rifugiati. I rifugiati sono infatti un gruppo di soggetti che, a causa degli eventi che hanno determinato la loro migrazione, sono particolarmente a rischio di patologia psicotraumatologica e la migrazione può avere per loro un effetto ritraumatizzante. Vengono descritti, in una prospettiva analitico transazionale, gli specifici problemi psicopatologici dei rifugiati traumatizzati, in specie di coloro che sono sopravvissuti alle torture, e vengono date indicazioni per la gestione psico-sociale delle loro difficoltà.
Abstract
TRAUMA AND MIGRATION. A TRANSACTIONAL ANALYSIS APPROACH TO REFUGEES AND TORTURE VICTIMS
This article presents a model that enables us to interpret migration, a phenomenon affecting a huge mass of people on our planet, as a traumatic event. The article describes factors of resilience and vulnerability affecting the psychic health of migrants, and in particular the effects that these events have on refugee populations. Refugees are in fact a group that, due to the events that have determined their migration, are particularly at risk of psycho-traumatic pathology, and migration can have a re-traumatizing effect on them. The specific psycho-pathological problems of traumatized refugees - in particular of those who have survived torture - will be described in a Transactional Analysis perspective; indications are also given for the psycho-social management of their difficulties.
Migrare
Benché possa apparire sorprendente ai nostri occhi di oggi, la vita stanziale è stata, nella storia dell'umanità, l'eccezione piuttosto che la regola. La specie umana è stata soprattutto una specie nomade, in movimento. Ancora oggi i migranti sono una massa enorme sul pianeta. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) le persone che vivono in un paese diverso rispetto a quello in cui sono nate sono 191 milioni; a queste vanno aggiunti circa 30-40 milioni di migranti irregolari (UNFPA, 2006; United Nations, 2006; Koser, 2005). Messi insieme costituirebbero idealmente il quarto paese più popoloso al mondo, dopo Cina, India e Stati Uniti.
Nell'Unione Europea (Caritas, 2007) gli stranieri soggiornanti all'inizio del 2006 erano oltre 27 milioni, ma questa cifra arriva forse a raddoppiarsi se si considerano le persone nate all'estero che hanno acquisito la cittadinanza del paese ospitante.
Una consistente parte di questi migranti sono rifugiati. L'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR 2007a, 2007b) riferisce che alla fine del 2006 erano circa 33 milioni i suoi assistiti (benché di questi oltre 12 milioni fossero sfollati interni al proprio paese e quindi tecnicamente non emigrati).
L'arrivo di una massa così consistente di popolazione (nell'Unione Europea gli stranieri contano per il 5,6% della popolazione complessiva, ma il dato può verosimilmente raddoppiarsi con le naturalizzazioni, Caritas, 2007) ha posto e pone sfide significative nella gestione di una tale formidabile risorsa umana.
Anche l'assistenza psichiatrica e psicoterapeutica ha dovuto e deve quotidianamente confrontarsi con cambiamenti tanto rilevanti del panorama demografico. In particolare i rifugiati costituiscono un gruppo ad alto rischio; tra questi vi sono sopravvissuti a torture, violenze di massa, lutti gravi che portano segni di severe patologie post traumatiche.
Tra le sfide che i nuovi scenari offrono agli psicoterapeuti e, più in generale, alle professioni di aiuto, vi è quella di trovare strumenti operativi in grado di funzionare efficacemente con una utenza multiculturale e di rispondere in modo adeguato ai bisogni di una popolazione segnata in modo consistente dalla psicotraumatologia.
Una strategia che sembra essere promettente è quella di considerare lo stesso evento "migrazione" da una prospettiva psicotraumatologica.
Il mio vocabolario (Devoto, Oli, 1990) definisce così il trauma: "Emozione improvvisa e violenta, capace di provocare un'alterazione permanente nell'attività psichica". Nella mia pratica clinica numerose osservazioni sembrano sostenere l'idea che la migrazione rappresenti un evento emotivo capace di determinare una trasformazione di tale fatta, quindi un trauma.
Non ho ancora incontrato nessun immigrato (me compreso, nelle mie esperienze di migrante) che non sia in grado di ricordare con grande vivezza il suo primo giorno in terra di migrazione, con quella lucidità e con quella partecipazione emotiva tipiche degli eventi traumatici (quando beninteso la gravità degli stessi non abbia indotto difese di dissociazione).
Nell'esperienza di tutti i miei interlocutori la migrazione ha segnato un cambiamento irreversibile nel proprio vedersi al mondo, una vera e propria cesura tra un prima e un dopo, a ricordarci l'etimologia del termine "trauma", che in greco antico significa "ferita". Per tutti coloro con i quali ho parlato le difficoltà sono state intense, benché esse siano state in genere superate con successo e l'esperienza sia a distanza di tempo considerata positiva. A ben vedere, per molti immigrati l'esperienza migratoria sembra configurarsi piuttosto come un trauma iniziatico, cioè come una di quelle prove più o meno ritualizzate a cui in talune culture vengono sottoposti i giovani o le persone che devono acquisire uno status diverso. La sofferenza superata diventa la prova del successo e il titolo di merito per una nuova dimensione sociale e psicologica. Questo sviluppo della personalità dopo un trauma è del resto documentata in letteratura (Tedeschi, Calhoun, 1996; Sironi, 1999; Allen, 2006): un evento stressante può costituire, grazie alla crisi che determina nel sistema di riferimento di chi ne è colpito, un'eccellente opportunità di ampliare i limiti del proprio copione di vita.
Secondo questa prospettiva, vedremo come sia possibile avvicinarsi alla psicologia (e quindi alla psicopatologia) dei migranti nello stesso modo con cui ci si accosta agli eventi traumatici: prendendo in considerazione i fattori di resilienza e quelli di vulnerabilità all'evento; in questo modo è possibile ottenere letture originali dei fenomeni e trarne anche promettenti strategie di intervento.
Un tale approccio può essere utile con i rifugiati. Come si è detto, costoro sono un gruppo fragile e di particolare interesse per la psichiatria e la psicoterapia. L'approccio alla migrazione come a un evento traumatico ci consente di identificare le loro peculiarità e anche di comprendere le difficoltà che a volte queste persone evidenziano nell'adattarsi al paese ospitante.
La seconda parte dell'articolo si riferirà alle strategie di intervento con questi pazienti, interventi di tipo riabilitativo in senso generale, non strettamente psicoterapeutico. Non entro qui nel merito di specifiche tecniche terapeutiche, dato che esse richiedono uno spazio che supera i limiti di questo articolo. Inoltre vi è una ragione epistemologica per questa scelta, poiché penso che il ruolo degli psichiatri e degli psicoterapeuti vada al di là del loro studio professionale. Si curano le persone nel territorio in cui vivono: la capacità di stimolare e realizzare reti integrate di assistenza psico-sociale, sinergiche tra loro, in grado di dare risposte complesse a problemi complessi è una caratteristica della buona psichiatria. Possiamo essere eccellenti terapeuti non solo nel chiuso dei nostri studi ma anche decidendo di essere attori sociali. In questo senso l'Analisi Transazionale, che è a mio parere un efficace strumento transculturale (Mazzetti, 2007), date le sue origini e la sua tradizione strettamente connesse con la psichiatria sociale, si integra bene con questa prospettiva.
Resilienza e Vulnerabilità
Il termine "resilienza" è entrato in anni recenti nel lessico psichiatrico. Esso ha origini distanti, che si trovano nella scienza dei materiali e in particolare nella metallurgia. Esprime la capacità di un materiale di resistere a urti e tensioni mantenendo le sue proprietà o riacquisendole al termine dell'evento traumatico. é stato efficacemente trasposto in ambito psichiatrico per esprimere la capacità di sopportare i traumi conservando una buona salute psichica.
Quali sono i fattori di resilienza in grado di aiutare a gestire il trauma della migrazione? Sulla base delle nostre esperienze cliniche e di quanto riportato dalla letteratura scientifica possiamo raggrupparli in due insiemi principali, quelli che fanno capo alle caratteristiche individuali e quelli connessi al progetto migratorio dell'individuo. Un terzo gruppo rilevante può essere individuato nel supporto sociale che l'immigrato trova sul suo cammino.
La Figura 1 riassume l'insieme dei fattori di resilienza.
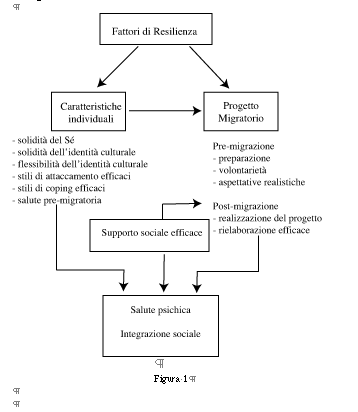
Caratteristiche individuali
é verosimile che una serie di caratteristiche individuali positive aiuti a gestire il trauma della migrazione, per quanto sia arduo ottenerne la dimostrazione scientifica. é infatti difficile costruire modelli di ricerca che consentano di comparare le condizioni psichiche pre-migratorie con gli esiti in termini di salute psichica e di integrazione sociale del soggetto immigrato. é del resto questo un problema metodologico ben conosciuto in chi si occupa di epidemiologia psichiatrica dell'immigrazione.
Poiché infatti ogni fase del processo migratorio è caratterizzata da molte variabili socio-ambientali interagenti, alcune delle quali possono mettere seriamente a rischio l'adattamento psicologico, si comprende come esistano notevoli differenze nella vulnerabilità dei migranti, a partire proprio dalle caratteristiche pre-migratorie, e da come la migrazione stessa sia nata (Mazzetti, 1996).
Proprio l'ampia variabilità dei fattori in gioco rende estremamente difficile sia tracciare un profilo epidemiologico psicopatologico dei migranti, sia identificarne i relativi fattori di rischio. Dall'analisi della letteratura pubblicata su migrazione e salute mentale (Bhugra, 2004) emergono infatti numerose limitazioni metodologiche (ad esempio eterogeneità dei campioni dal punto di vista etnico, culturale e migratorio; diversità dei settings di ricerca e degli strumenti di valutazione; carenza di studi longitudinali a lungo termine) che spiegano la presenza di dati contrastanti e rendono difficili le estrapolazioni da una popolazione all'altra e le generalizzazioni.
Le evidenze degli ultimi decenni sembrerebbero indicare tassi di prevalenza leggermente maggiori per alcuni disturbi psichiatrici negli immigrati (in particolare per la schizofrenia, Bhugra, 2004), mentre per quanto riguarda disturbi mentali più comuni come quelli depressivi (Bhugra, 2003), d'ansia e l'abuso di sostanze i dati sono meno chiari. Esiste qualche evidenza, inoltre, del fatto che, con l'andare del tempo, gli immigrati tendano ad avvicinarsi ai profili epidemiologici delle popolazioni ospiti.
Quando noi parliamo di caratteristiche individuali ci riferiamo quindi a quanto possiamo osservare nel setting clinico e a quanto siamo in grado di ricostruire nel corso del lavoro con i nostri pazienti.
Solidità del Sé: la realizzazione della migrazione comporta, soprattutto quando avviene da paesi in via di sviluppo, una serie di difficoltà spesso particolarmente intense, e può quindi agire come filtro positivo che lascia passare soprattutto le persone più abili, coraggiose, motivate e sane. Queste risorse di partenza hanno un ruolo protettivo dal punto di vista della salute mentale e costituiscono una base solida di partenza che può proteggere notevolmente il migrante, soprattutto nelle prime fasi della migrazione. é facile intuire che questo tipo di selezione, però, funziona essenzialmente con i cosiddetti "pionieri della migrazione", coloro cioè che partono per primi, intenzionalmente e con forti motivazioni. Essa si riduce fino a scomparire nelle migrazioni successive (ad esempio nei ricongiungimenti familiari) o addirittura a invertirsi nelle migrazioni forzate dei rifugiati. Personalità solide, capaci di conoscere e comprendere se stessi e gli altri e con un'esperienza di vita di successo agevolano in genere un buon adattamento. Queste caratteristiche del resto sono coerenti con la letteratura psicotraumatologica: Allen suggerisce che i migliori esiti dopo un trauma dipendano dalla capacità di mentalizzare, cioè di concettualizzare sé e gli altri in base ai pensieri e alle emozioni di ciascuno e di comportarsi di conseguenza (Allen e coll., 2004; Allen, 2006) e Fonagy e collaboratori (Fonagy e coll., 1994) sostengono che questa capacità di pensiero sia un fattore chiave nel promuovere la resilienza. Queste caratteristiche esprimono efficacemente il concetto di personalità solida.
Solidità e flessibilità dell'identità culturale: queste due caratteristiche sembrano andare di pari passo. Possiamo definire l'identità culturale come la capacità di riconoscersi in un coerente sistema di valori e di rappresentazioni del mondo. Avere un'identità culturale solida appare essere come un porto di partenza sicuro: di lì, con l'aiuto di buoni strumenti, è facile tracciare una rotta. Partire da un'identità culturale fragile è come iniziare un viaggio da un punto sconosciuto in mezzo al mare: identificare la rotta è assai più complesso. Identità culturali solide consentono un buon processo di negoziazione con le realtà che si incontrano in terra di migrazione e quindi una valida flessibilità. Al contrario identità fragili sono frequentemente alla base di vissuti di insicurezza, di timore, che facilitano chiusure difensive e rigidità nell'adattamento. é facile osservare in questi ultimi soggetti, ad esempio, l'arroccarsi in modo ossessivo a pratiche religiose nel tentativo di ancorarsi a un punto fermo per poter resistere alle richieste di adattamento della società ospitante.
Stili di attaccamento efficaci: l'attaccamento è uno strumento utile in etnopsichiatria perché è un concetto che ha dimostrato una buona validità in ambito transculturale. Esso si sviluppa e si consolida in modo sostanzialmente simile ovunque, nella specie umana (Schaffer, 1998). Un attaccamento sicuro, che in età adulta può corrispondere a quello che Mary Main e collaboratori hanno definito posizione "autonoma" (1985), è uno strumento utile per l'adattamento alla nuova realtà, facilitando l'instaurarsi di nuove relazioni sane nel nuovo contesto. Quando ci attiviamo per costruire relazioni terapeutiche solide non stiamo solo preparando un necessario strumento per le successive operazioni cliniche, ma a mio parere stiamo attivamente curando disturbi dell'attaccamento.
Stili di coping efficaci: la capacità di coping, cioè di gestire efficacemente l'evento traumatico, è propria di ogni individuo. Ognuno ha le sue risorse innate e sviluppate nell'intero corso della vita; queste risorse possono anche essere apprese, affinate e sviluppate, e proprio l'addestramento al coping costituisce una delle possibili strategie nella psicoterapia con i migranti.
Salute psichica pre-migratoria: una storia di benessere psichico prima della partenza sembra essere un fattore prognostico positivo riguardo alla capacità di gestire il trauma della migrazione.
Progetto migratorio
Il progetto migratorio sembra essere di una rilevanza decisiva nel proteggere la salute psichica dei migranti (Frighi et al., 1993; Mazzetti, 1996). La ragione è duplice. Il progetto migratorio racchiude in sé l'insieme delle motivazioni che hanno portato la persona a impegnarsi nella difficile avventura della migrazione, e livelli elevati di motivazioni consentono agli esseri umani di fare fronte a molte difficoltà: se il progetto migratorio in qualche modo funziona, i migranti riescono a sopportare prove notevoli conservando la loro salute.
La seconda ragione, più profonda e probabilmente più rilevante, è legata al fatto che il progetto migratorio si configura come il fattore capace di dare un senso alla storia di vita dell'individuo, di tenere unite con una narrazione due immagini di sé (quella prima della migrazione e quella successiva) non di rado scisse dalla frattura dell'evento migratorio, fornendole di un significato che consente di rammendare la sua trama esistenziale. Riferendoci al modello proposto da Stuthridge (2006), possiamo dire che il progetto si può configurare come la narrativa in grado di integrare diverse esperienze di sé.
Quando il migrante parte, infatti, è consapevole di lasciare la sua terra e le persone care, ma scoprirà solo all'arrivo di avere detto addio anche a qualcun altro: a se stesso così com'era prima di partire. L'esperienza migratoria incide profondamente sulla percezione della propria identità e una delle sfide terapeutiche più rilevanti è quella di aiutare il paziente a ricostruire un senso di continuità tra il sé di prima e il sé di dopo. Il progetto migratorio è in grado di svolgere un ruolo primario in questo processo.
Un progetto prevede la volontarietà dell'atto e la sua preparazione, e tanto più ha successo quanto più è realistico e flessibile, e può quindi venire rielaborato e adattato se la realtà nel paese ospite non corrisponde alle aspettative di prima della partenza. Le caratteristiche individuali descritte in precedenza sono in grado di influire positivamente, come è facile intuire, sulla creazione e sulla realizzazione del progetto migratorio.
Supporto sociale adeguato
Un supporto sociale efficace è quello in grado di sostenere l'individuo sia emotivamente che nei suoi bisogni materiali, che lo accompagna nella realizzazione del progetto migratorio e ne favorisce l'integrazione sociale e psicologica nella nuova realtà. Può essere dato da una grande varietà di attori sociali: familiari e amici arrivati in precedenza, agenzie pubbliche o del privato sociale eccetera.
La presenza di familiari o di membri del gruppo culturale di appartenenza nel paese ospite influenza notevolmente il grado di supporto sociale, che ha un ruolo dimostrato di "fattore tampone", protettivo nei confronti delle risposte psicopatologiche agli eventi traumatici (GorstUnsworth e Goldenberg, 1998). Essa tuttavia può avere anche un effetto paradossalmente opposto, di condizionamento che ostacola l'integrazione sociale. é un fenomeno talora osservato nelle seconde generazioni, quando la famiglia impone uno stile di vita e regole coerenti con il paese di origine, ma che possono frenare la naturale integrazione dei giovani nella terra ospite.
Il supporto sociale, infatti, deve essere oltre che presente anche efficace, cioè capace di sostenere e promuovere effettivamente l'integrazione psico-sociale. Non sempre un supporto sociale intenso è anche utile in questa direzione.
Un esempio di supporto sociale intenso e controproducente può essere il seguente: nei primi anni '90 in Italia sono arrivate notevoli ondate migratorie dalla Somalia, in seguito ai disordini sociali e alla guerra civile scatenati nel paese. Le comunità somale immigrate erano numerose e coese, il supporto sociale che offrivano ai membri era intenso. Ma una delle conseguenze di questo fenomeno fu il riprodursi nel paese ospite della pratica dell'infibulazione a danno di alcune bambine. Si comprende bene come, per queste ultime, il supporto sociale non fu affatto benefico: oltre a mutilarle provocando un danno biologico irreversibile il gesto serviva anche a emarginarle dal contesto delle loro coetanee italiane.
Fattori di rischio
Già da un primo sguardo ai fattori di resilienza appare intuitivo identificare gruppi di individui meno protetti e quindi potenzialmente più fragili nei confronti del trauma della migrazione. Essi sono, in primo luogo, le persone che migrano senza un progetto, senza quindi un fattore motivante e proteggente nei confronti della crisi identitaria che ogni migrante si trova ad affrontare (Mazzetti, 2003). Gli individui senza progetto sono sostanzialmente le vittime di migrazioni forzate: rifugiati e richiedenti asilo, ma anche familiari ricongiunti di immigrati, ad esempio i loro figli minorenni. Questi ultimi si trovano a volte a dover affrontare il trauma della migrazione in condizioni particolarmente difficili senza significativi fattori di resilienza.
Gli stessi due gruppi appena citati (rifugiati e familiari ricongiunti) sono tra coloro per i quali possono esserci maggiori problemi a proposito delle caratteristiche individuali, dato che le vicissitudini della vita (le persecuzioni subite per i rifugiati, le eventuali separazioni traumatiche dai genitori e altri familiari significativi per i bambini) possono averle indebolite.
La Figura 2 riassume i fattori di rischio per la salute dei soggetti che hanno affrontato il trauma della migrazione.
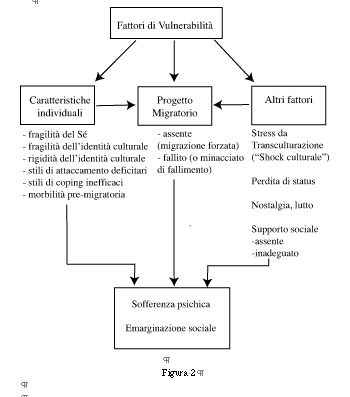
Caratteristiche individuali
Esse appaiono speculari a quelle descritte a proposito dei fattori di resilienza. Se fermiamo l'attenzione sui rifugiati, la storia della loro vita può avere gravemente danneggiato le loro caratteristiche individuali, specie se sono stati vittime di violenze o di torture. Sappiamo che uno degli effetti della violenza intenzionale (spesso espressamente cercato da chi la perpetra) è quello di danneggiare il Sé delle persone, di mettere fuori uso i loro meccanismi di coping e di scompaginare le dinamiche di attaccamento (Sironi, 1999).
Quanto agli effetti sull'identità culturale, la nostra esperienza di clinici ci pone frequentemente di fronte a un'osservazione comune: poche persone si assomigliano le une alle altre come i pazienti affetti da gravi forme di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) o da altre severe patologie post-traumatiche, quasi che la loro personalità (e con essa la cultura) scompaia, per ridurre gli individui che ne soffrono agli elementi più basilari dell'esistenza umana. Gli effetti della violenza sistematica sono stati magistralmente descritti, prima ancora che dagli psichiatri, dallo scrittore italiano Primo Levi, vittima del nazismo. Il suo resoconto della vita nel lager di Auschwitz (Se questo è un uomo) introduce meglio di tanti trattati scientifici all'esperienza fenomenologica delle vittime di violenza (Levi, 1947).
é quanto l'etnopsichiatra francese Franoise Sironi (Sironi, 1999) chiama "riduzione all'universale", che significa deculturizzare l'individuo, separarlo dai suoi e dalla stessa specie umana, come con efficacia descrive un altro romanziere, il francese Daniel Pennac (1990): « ... la tortura non consiste solo nel far male, consiste nel desolare un essere umano fino ad allontanarlo dalla specie umana, niente più a che fare, solitudine urlante ... ».
La tortura, le violenze sistematiche, i genocidi, i sovvertimenti del mondo, come sono stati tra gli altri, negli ultimi decenni, i casi della Cambogia, della Ex-Jugoslavia e del Ruanda, hanno sortito in molti casi questo risultato. Esseri umani che sono stati separati dalla loro umanità, che si esprime attraverso la cultura.
Quanto alle condizioni di salute psichica, una serie crescente di evidenze sta svelando alti tassi di sofferenza psichica negli immigrati che hanno subito oppressioni, torture e altre forme di violenza organizzata. Sottogruppi di rifugiati esposti a traumi di guerra mostrano un'alta morbilità psichiatrica a lungo termine, anche dopo molti anni (Steel et al., 2002). Le esperienze post-migratorie, come vedremo più avanti, peggiorano la situazione: il disagio e i sintomi psichiatrici si aggravano dopo l'arrivo nei paesi ospiti.
Studi epidemiologici hanno evidenziato che il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) e i disturbi depressivi sono i due quadri clinici psichiatrici più diffusi e più facilmente misurabili nelle popolazioni di rifugiati, con poche differenze tra culture diverse. Spesso sono in comorbilità e hanno prevalenze significativamente maggiori nei rifugiati messi a confronto con popolazioni di non rifugiati (Cardozo et al., 2000; Mollica et al., 1993, 1999; Victorian Foundation for Survivors of Torture, 1998). Anche altri disturbi d'ansia, i disturbi da somatizzazione e altri sintomi di disagio "misti" sembrano estremamente probabili in questi gruppi (Turner e Gorst-Unsworth, 1990).
Nella nostra esperienza clinica non sembrano essere rare reazioni paranoidi che a volte configurano un vero e proprio quadro di disturbo della personalità: non è stato possibile capire se si trattasse di quadri clinici almeno in parte preesistenti al trauma o se vi sia un rapporto di causa ed effetto con quest'ultimo. Esistono, come vedremo, elementi che ci lasciano ipotizzare una relazione causale con l'evento stressante.
Inoltre, sempre riferendoci alla morbilità pre-migratoria, è stata ben documentata una solida associazione dose-risposta tra traumi e sofferenza psichica: un'esposizione cumulativa a traumi (subire violenze o torture, essere costretti a lasciare la propria casa, trovarsi vicino a sparatorie ed esplosioni, pericolo di morte per se stessi e per i familiari) corrisponde ad un aumento progressivo del rischio di morbilità psichiatrica (Mollica e coll., 1998a, 1998b; Turner e coll., 2003; Chung e Kagawa-Singer, 1993; Cheung, 1994), coerentemente con quanto si sa a proposito della maggior vulnerabilità ai traumi di chi è stato già traumatizzato. Nei gruppi di rifugiati da zone di guerra le percentuali di esposizione multipla a questi eventi sono elevatissime (Turner et al., 2003).
I rifugiati possono dunque soffrire di caratteristiche individuali pesantemente deficitarie al momento dell'arrivo in terra di immigrazione, e essere quindi privi di questo basilare fattore di resilienza.
Progetto migratorio
Si è già detto in precedenza del valore del progetto migratorio come fattore di resilienza, e di come proprio la sua mancanza in alcuni gruppi (minori, rifugiati) o individui possa rivelarsi un decisivo fattore di vulnerabilità. Il progetto però può anche essere esistito in partenza ed essere fallito (o minacciato di fallimento) perché era scarsamente realistico, o poco flessibile, o perché qualche vicissitudine (una malattia, ad esempio) lo ha danneggiato.
Nelle strategie terapeutiche con gli immigrati talora è necessario programmare una vera e propria "terapia del progetto" che consenta di lavorare per ricostituire questo fondamentale elemento di resilienza.
Un aspetto chiave nella "psicoterapia del progetto" è la ricognizione dei diversi aspetti di cui è costituito. Mentre infatti quasi tutti gli immigrati sono consapevoli della motivazione di tipo economico (trovare un buon lavoro, guadagnare bene) non sempre lo sono altrettanto di altre componenti meno evidenti (rifarsi una vita dopo un fallimento matrimoniale, sperimentarsi in un nuovo contesto, desiderio di viaggiare e conoscere il mondo, liberarsi da relazioni familiari difficili, vivere in un contesto di libertà civili e democratiche) che hanno altrettanto bisogno di venire comprese ed elaborate.
Con i rifugiati la questione del progetto appare particolarmente delicata. Nella maggior parte dei casi un progetto migratorio in senso stretto non esiste. O meglio: esso si è realizzato nel momento in cui si è lasciato il proprio paese: il progetto era salvarsi la vita. Esistono però, e sono di frequente nascoste o inconsce, fantasie sul futuro di improbabile realizzazione e che servono sostanzialmente a mantenere il soggetto bloccato. Esse sono sia di tipo sociale (la fantasia che le condizioni del loro paese cambino radicalmente e che tutto torni come prima, ad esempio) che personale (torneranno esattamente quelli di prima del trauma o della fuga) e si configurano come le "fantasie" descritte nel Sistema Ricatto da Erskine e Zalcman (1979), qualcosa di funzionale al mantenimento di un sistema copionale bloccato.
Atteggiamenti simili sono stati descritti da Jim Allen (2006) tra i sopravvissuti all'attentato a Oklahoma City del 1995: aspettative irrealistiche tendono ad agganciare le persone nei ruoli del triangolo drammatico e a ostacolare i processi di resilienza.
Altri fattori
Tra i fattori di rischio ve ne sono alcuni che esercitano la loro azione indirettamente, minacciando la riuscita del progetto migratorio, altri come specifiche noxae patogene.
Lo stress da transculturazione, qualcosa di simile a ciò che gli antropologi chiamano shock culturale, è l'insieme di eventi traumatici che si accompagnano all'impianto nel paese ospite.
Con il termine stress da transculturazione definiamo quindi in modo complessivo l'insieme di fenomeni che interessano il migrante nel suo passaggio da una terra a un'altra. La complessità di stimoli è tale che non può venire sistematizzata in ogni sua parte. Possiamo però qui segnalare alcuni aspetti che possono concorrere a formarla: la lingua, spesso incomprensibile all'inizio, che richiede tempo per essere appresa e da cui però dipende la sopravvivenza dell'immigrato fin dai primi giorni; il complesso delle comunicazioni non verbali, talora ancora più difficili da decrittare e apprendere che la lingua; la percezione di avere un corpo straniero, cioè di portare tratti somatici che indicano immediatamente un'appartenenza estranea, che possono essere bersaglio di atteggiamenti razzisti o comunque emarginanti e che possono dare ragione di alcuni frequenti disturbi psicosomatici come il prurito sine materia (Mazzetti, 1996, 2003); la crisi etica determinata dall'osservare un sovvertimento nei costumi che può essere fonte di confusione negli immigrati: si pensi ad esempio l'effetto che può avere in chi proviene da luoghi in cui le donne sono velate integralmente trovarsi in una città del mondo occidentale in una giornata estiva.
La distanza geografica dal paese d'origine e, soprattutto, la distanza culturale sembrano essere particolarmente rilevanti nel determinare l'intensità dello stress da transculturazione: il passaggio, ad esempio, da società socio-centriche (strutturate in modo cioè che la propria identità sia determinata soprattutto dal senso di appartenenza a un certo gruppo) a culture ego-centriche, tipiche delle società occidentali, a impronta fortemente individualistica, o da ambiente rurale a contesto urbano.
Un altro elemento chiave è la perdita di status sociale. L'effetto patogeno di questa situazione è, in particolare tra i rifugiati, la regola: molti di essi lasciano nei paesi d'origine alti standard di vita e occupazionale (professionisti della salute, insegnanti, giornalisti, uomini politici eccetera, Sinnerbrink et al., 1997), ed è difficile che riescano a far riconoscere le loro qualifiche nei paesi in cui sono ospiti (Burnett, Peel, 2001a, 2001b). La loro salute mentale è quindi messa a rischio dall'unione di esperienze passate e presenti: ai traumi subiti nei paesi di origine si sommano la perdita di identità e di status, a volte anche ulteriori violenze, razzismo e discriminazione (Levenson e Coker, 1999). La povertà, inoltre, il cui effetto negativo sulla salute fisica e mentale è ben documentato, è una condizione molto probabile per i rifugiati (Connelly e Schweiger, 2000).
In questa popolazione sono la regola anche le perdite e i lutti (di persone fisiche, spesso, e sempre della propria terra e del proprio mondo socio-affettivo, Mazzetti, 1999).
Il supporto sociale spesso manca, perché con frequenza il rifugiato arriva solo, con modalità casuali, in un paese non scelto: questa è la situazione che osserviamo più comunemente in Italia. Quando anche il rifugiato, come nel caso di fughe all'interno di un paese, o in paesi vicini, si muove in gruppo, le persone con cui fugge possono non essere in grado di offrirgli supporto sociale, perché anch'esse traumatizzate e sofferenti. In uno studio su rifugiati iracheni, le variabili sociali durante l'esilio, in particolare la presenza di supporto socio-affettivo, si sono rivelati così importanti nel determinare la severità della sintomatologia psichiatrica da essere addirittura più rilevanti dei traumi subiti nel paese d'origine (GorstUnsworth e Goldenberg, 1998). Una variabile che si è rivelata fondamentale per lo sviluppo di psicopatologia è la separazione dalla famiglia (Turner et al., 2003), non a caso condizioni abitative difficili e isolamento sociale sono stati associati a maggiori livelli di depressione (Van Velsen et al., 1996).
Il rifugiato si configura, quindi, come un immigrato in cui i fattori di vulnerabilità sopravanzano ampiamente quelli di resilienza. In queste condizioni, la migrazione può agire (e molto spesso agisce, nella nostra esperienza) come un potente agente ritraumatizzante.
L'Analisi Transazionale e il trauma dei rifugiati
Dal punto di vista della teoria analitico-transazionale, la psicotraumatologia costituisce una sorta di experimentum naturae che mette in evidenza come elementi decisivi dell'apparato del copione di vita possano essere fatti propri anche ben più tardi della prima infanzia, purché le condizioni siano tali da determinare un forte coinvolgimento emotivo, e suscitare la necessità di una nuova risoluzione intrapsichica per sopravvivere in una situazione critica.
Si tratta quindi di una sorta di dimostrazione sul campo di quanto affermava Cornell (1988, pag. 281): «rilevanti decisioni di copione possono essere prese in ogni momento della vita».
Vern Masse (1995), discutendo del trattamento del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD), propone in questo modo lo stabilirsi di nuove decisioni di copione (pag. 356): «In reazione a un trauma estremo (...), un soggetto può regredire spontaneamente a una fase precoce dell'età evolutiva, e prendere nuove decisioni riguardo sé, gli altri e il mondo».
La mia opinione è che, analogamente a quanto detto da Cornell e Masse a proposito delle decisioni di copione, anche nuove ingiunzioni possano venire incorporate in ogni età della vita. Già i primi autori di Analisi Transazionale (tra gli altri Berne, 1972, e Steiner, 1966) sostenevano le caratteristiche non-verbali, o meglio pre-verbali dell'ingiunzione. La mia ipotesi è che non sia neppure necessario pensare in termini di regressione per ammettere l'incorporazione di una ingiunzione anche in tempi molto successivi alla prima infanzia. Gli avanzamenti nelle neuroscienze infatti possono consentirci di ipotizzare un modello esplicativo dello stabilirsi di ingiunzioni in qualsiasi fase della vita, in seguito all'azione di eventi che impressionano significativamente le aree neurologiche deputate alla memoria implicita (in particolare talamo, amigdala, ippocampo e corteccia pre-frontale). Benché queste siano, in effetti, le strutture dominanti nei processi di memorizzazione/apprendimento relazionale nelle prime fasi della vita, non smettono certo di essere attive nelle fasi successive e ben possono essere alla base di "apprendimenti" non verbalizzabili come appaiono essere le ingiunzioni; in questo caso "i ricordi vengono archiviati come stati affettivi o come modalità senso-motorie, come sensazioni fisiche e immagini visive" (van der Kolk, 1996).
Secondo Armin Beslija (1997), che ha descritto le sue esperienze psicoterapeutiche con i rifugiati bosniaci, la decisione di sopravvivenza che, di fronte all'intensità del trauma e al pericolo per la propria vita, le persone affette da PTSD prendono è collegata a un'ingiunzione a "non sentire"; il trauma sarebbe tale che le vittime decidono inconsapevolmente di azzerare le proprie emozioni e di escludere il proprio Stato dell'Io Bambino.
Io non sono d'accordo con questa osservazione. Penso che una situazione simile possa forse verificarsi a volte in presenza di significative difese di dissociazione e di imponenti sintomi di evitamento, ma nella mia esperienza si tratta di un evento non frequente.
Mi pare che le ingiunzioni in gioco siano, in realtà, altre, e che queste ricorrano non solo in presenza di PTSD ma anche negli altri quadri clinici conseguenti al trauma, come i disturbi depressivi, d'ansia o quelli paranoidi o evitanti di personalità.
In base alla mia esperienza, l'impatto con un evento traumatico del tutto fuori dalle possibilità di gestione dell'individuo, induce in quest'ultimo una sensazione di profonda insicurezza che si traduce in un'ingiunzione "non fidarti".
La persona sente, in primo luogo, di non potersi fidare delle proprie capacità di gestione della realtà; si tratta, quindi, di una sfiducia rivolta innanzi tutto verso se stessa, che comporta elevati livelli di ansia. Inoltre, quando l'evento traumatico, anziché a cause naturali, è dovuto alla crudeltà di altri esseri umani (come è quasi la regola nel caso dei rifugiati), si traduce anche in una profonda e generalizzata sfiducia nei confronti degli altri e dell'intera umanità.
Queste considerazioni mi sembrano il presupposto teorico per spiegare i quadri clinici paranoidi che talora incontriamo nei nostri pazienti vittime di violenza. In base alla mia esperienza i pazienti con sintomi paranoidi sono, prima ancora che persone che diffidano degli altri, soggetti che non si fidano di sé, della propria capacità di proteggersi e di discriminare tra gli altri chi sono le persone pericolose e chi no. Questa profonda sfiducia personale è proprio anche ciò che a volte le torture inducono intenzionalmente nelle vittime (Sironi,1999).
Come ho detto, non sono invece d'accordo con l'ingiunzione "non sentire". Mi pare, anzi, che le persone affette da PTSD e dagli altri quadri clinici "sentano" le loro emozioni, ne siano addirittura invase, anche se le combattono, o le mistificano con i sentimenti-ricatto: anziché la rabbia "sentono" la paura, oppure anziché la paura si permettono la tristezza. Piuttosto che di un Bambino escluso (benché alcune aree di esclusione siano di regola presenti), mi pare che si possa parlare di gravi contaminazioni del Bambino sull'Adulto, che non è più in grado di discriminare, di dare un senso alle proprie emozioni. Piuttosto che di un "non sentire" mi pare che si possa parlare di un "non pensare", inteso come non discriminare, non riconoscere le proprie emozioni, non riuscire a collocarle in un senso, anche perché la vera sfida per i soggetti traumatizzati è riuscire a ricostruire un senso all'esperienza che hanno vissuto: in questo concordo con Stuthridge (2006) che sostiene l'importanza di sviluppare una narrazione coerente di quanto è avvenuto per guarire dal trauma.
In base alla mia esperienza, penso che la guarigione dalla patologia post traumatica sia una strada da percorrere attraverso la porta d'accesso del livello cognitivo: riuscire a dare un senso a quanto è avvenuto, al comportamento dei persecutori, ai propri stessi comportamenti sembra essere la via maestra. é quanto consente di ristabilire una narrativa coerente della propria esperienza di vita. Le emozioni in questa prospettiva vanno in primo luogo legittimate, poi comprese, spiegate e fornite di senso, più che rivissute; questa strategia, tra l'altro, consente di attivare minori resistenze perché, al contrario, tecniche regressive basate sulla ri-esperienza emotiva possono portare a contatto con vissuti intollerabili.
A completare l'apparato di copione osservabile come conseguenza dei traumi, le spinte che sembrano ricorrere con maggiore frequenza sono "Sii forte", declinato come "combatti con tutte le tue forze contro quello che provi", e "Metticela tutta", ovvero "sforzati in tutti i modi di tenere a bada le tue emozioni".
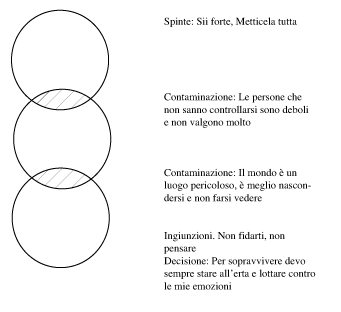
Figura 3
Patologia strutturale e messaggi di copione di frequente osservazione
nei pazienti affetti da patologia post-traumatica
Queste spinte si esprimono spesso come una contaminazione del Genitore sull'Adulto: il paziente tende a percepirle come dati di realtà, frutto di un pensiero adulto, che, in termini critici, ricorda alla persona che non va bene, perché non è capace di farcela, cioè di mettere sotto controllo i suoi vissuti interiori; questo tipo di contaminazioni giocano un ruolo primario nei vissuti depressivi. Il quadro complessivo può essere schematizzato nella Figura 3.
Questa violenta lotta contro se stessi è quella che assorbe gran parte delle energie di chi soffre di PTSD e di altre patologie post-traumatiche, tanto da lasciarne poche disponibili per avviare il processo di guarigione. Il paziente combatte contro i suoi ricordi, contro le sue emozioni, e proprio così facendo li carica di nuova energia. é quanto avviene comprimendo una molla: se ne aumenta la forza propulsiva. Per prendersi cura di queste persone è utile lasciare scaricare la molla della sua energia, in primo luogo legittimando il malessere come reazione "normale" a un evento anormale, e poi dando parole al dolore, fornendolo di senso, perché la vita psichica della persona possa riprendere in pieno.
Questa situazione raggiunge la sua massima gravità negli esiti di tortura.
La tortura "scientifica", che si è andata diffondendo nel XX secolo, in specie dopo la seconda guerra mondiale e quando le prime evidenze in psicologia sperimentale ne hanno offerto le basi scientifiche, mira sostanzialmente a ottenere tre cose:
1. Distruggere la fiducia dell'individuo in se stesso;
2. Distruggere la fiducia dell'individuo negli altri esseri umani;
3. Convincerlo della sua indegnità ad esistere.
La tortura mira a ripetere in modo ossessivo eventi traumatici in modo da portare questa situazione a livelli intollerabili per la persona, e a indurre meccanismi autorinforzantesi. Lo scopo finale della tortura è infatti quello di stabilire un processo in grado di automantenersi, in modo che l'individuo, una volta liberato fisicamente dai torturatori, continui il processo di auto-tortura a livello intrapsichico.
Il primo passo è quello di indurre e consolidare una situazione di totale impotenza. In molti casi il primo passo di una tortura è arrestare una persona, chiuderla in isolamento, e "dimenticarla" lì, magari al buio. L'individuo rimane ore, giorni, senza alcuno stimolo esterno, a tormentarsi su quanto potrà accadergli, in una condizione effettiva di impotenza assoluta.
A questa fase più o meno lunga seguono le violenze fisiche. Il senso di impotenza è dato dalla percezione del proprio corpo abbandonato senza alcuna possibilità di difesa nelle mani dei carnefici, in modo da portare la vittima alla sensazione di avere perduto ogni controllo su se stessa. Molto spesso la violenza è scollegata dall'obiettivo di estorcere informazioni: come conseguenza l'individuo non può influire su quello che gli sta avvenendo nemmeno confessando per interrompere le brutalità. Egli è, semplicemente, un corpo gettato nelle mani dei carnefici che ne dispongono a volontà.
Oltre alla sensazione di avere perso il controllo sul proprio corpo, primo passo per indurre la perdita di fiducia in sé, gli aguzzini mirano a infondere nella vittima la convinzione di non potere nemmeno controllare più il proprio pensiero. I metodi con cui questo obiettivo viene ottenuto sono diversi; uno dei più praticati è quello della privazione del sonno, a cui si aggiungono stimolazioni sensoriali bizzarre e illogiche. Testimonianze dalla ex-Iugoslavia parlano di vittime appese al palo a cui, negli intervalli tra una sessione e l'altra di violenza fisica, venivano proiettate immagini bizzarre, oppure venivano circondate da persone che le ignoravano, e facevano altro con la più grande disinvoltura, come se il torturato non esistesse (ad esempio, una coppia entrava e aveva un rapporto sessuale davanti a lui). Scopo di queste stimolazioni è, come si è detto, quello di portare l'individuo a credere di impazzire, di perdere il controllo della sua capacità cognitiva.
Frequenti sono anche le torture mirate a tenere l'individuo costantemente al confine tra la vita e la morte: tipiche sono, da questo punto di vista, le finte esecuzioni. La vittima viene portata davanti a un plotone di esecuzione (che magari ha appena giustiziato davanti a lui un'altra persona), si compiono tutti i rituali, e poi gli incaricati sparano a salve, per, subito dopo, deridere e umiliare le reazioni emotive del torturato.
Oltre a queste procedure, efficaci soprattutto per distruggere la fiducia dell'individuo in se stesso e nell'umanità, ne esistono altre che influiscono direttamente sulla sopravvivenza della vittima.
Mancano dati epidemiologici precisi (perché ciò che riguarda i sopravvissuti alle torture è nebuloso, oscuro: fa parte del quadro clinico il tentativo di nascondersi, di scomparire, di non cercare cure), tuttavia non sono pochi i casi di suicidio di cui vengono a conoscenza coloro che si occupano dei rifugiati.
La spiegazione di questi suicidi non è probabilmente univoca. A volte sembra che l'esito diretto della tortura sia l'induzione di un'ingiunzione "Non esistere", e di conseguenti nuove decisioni di copione correlate; in altri casi il suicidio sembra piuttosto configurarsi come una via d'uscita da un copione divenuto intollerabile.
Nel primo caso l'individuo viene convinto dalla tortura della sua indegnità a vivere, ad esempio inducendo vissuti di auto-colpevolizzazione intollerabili: tipicamente mostrando alla vittima come, a causa sua, altre persone sono state rovinate. Il carnefice ottiene questo risultato facendo assistere la vittima alle torture di suoi amici, e convincendola che è a causa sua che vengono torturati, oppure sottoponendo a violenze le persone più care, i familiari più stretti, sotto gli occhi della vittima.
Testimonianze in questo senso, frequenti nelle dittature latino-americane nella seconda metà del secolo scorso, sono venute in anni successivi dall'Irak o dall'Ex-Jugoslavia, dove a volte si costringeva il torturato a giustiziare con le sue mani parenti o amici. In questi casi il suicidio sarebbe la conseguenza di nuove decisioni di copione e avrebbe una finalità espiatoria (ad esempio: "non ho diritto a vivere per quanto male ho fatto, devo pagare per la mia colpa").
In altri casi, come si diceva, il suicidio appare piuttosto come una via di uscita da un copione ormai intollerabile costituito dalla sofferenza dovuta alle nuove convinzioni su di sé ("sono una persona fragile, debole e sola, senza speranza"), sugli altri ("sono crudeli", "nessuno mi capisce", "nessuno si cura di me") e sul mondo ("un luogo insicuro, instabile, incontrollabile e pericoloso").
L'aguzzino raggiunge il suo obiettivo quando il torturato, desolato sul piano psichico, ha ormai avviato un circolo vizioso di auto-punizione che garantisce che continuerà ad autoinfliggersi la condanna anche in futuro: a quel punto la vittima può venire liberata. Non è più in grado di nuocere al regime: può ormai nuocere solo a se stesso e alla propria causa.
Il trauma e la migrazione
Anche se non sono molte le ricerche estensive sui fattori post-esilio in grado di influire sulla morbilità psichica dei rifugiati, esse sono comunque concordi (e con queste l'esperienza clinica quotidiana) nel sottolinearne l'impatto, accompagnate dall'osservazione che con frequenza il disagio e i sintomi psichiatrici dei rifugiati si aggravano dopo l'arrivo nei paesi ospiti.
Come si è detto, un soggetto che abbia sofferto di traumatismi psichici verrà più facilmente traumatizzato se esposto nuovamente a stressors, con un processo di sommatoria del danno.
Il rifugiato traumatizzato, quindi, non è solo un soggetto più fragile in quanto migrante, perché in lui i fattori di vulnerabilità sono dominanti rispetto a quelli di resilienza, ma lo è anche nello specifico della psicotraumatologia, perché essendo già stato traumatizzato è particolarmente vulnerabile a nuovi traumi.
La migrazione agisce come evento ri-traumatizzante con tre modalità principali:
- Creazione di un contesto deculturizzante: lo stress da transculturazione agisce in modo più profondo e violento nel paziente che sta già soffrendo di una crisi della propria identità culturale, che è stato "deculturizzato" dalle violenze, dai sovvertimenti sociali e/o dalla tortura.
- Solitudine sociale: spesso il richiedente asilo viene alloggiato in luoghi in cui è riunito con altre persone solo in base al fatto di condividere con queste uno status giuridico, e si trova quindi a convivere con individui di cui non parla la lingua e non comprende le abitudini, il che accentua la sua percezione di isolamento e di estraniamento dall'ambiente circostante. Evento ritraumatizzante per chi ha perduto tutti i suoi contatti sociali, oltre che le relazioni affettive più intime.
- Esposizione a stimoli scatenanti: i primi contatti con la terra ospite avvengono spesso con militari o forze di polizia, e l'esposizione alle divise può essere, in soggetti con aumentato arousal come è tipico del PTSD, uno stimolo ansiogeno violento, se hanno imparato a temerle. Anche i centri in cui i richiedenti asilo sono ospitati, che a volte sono strutturati come luoghi di detenzione (ospiti reclusi, sbarre alle finestre), possono costituire una situazione ritraumatizzante per chi ha sperimentato la reclusione; in alcuni casi sono detenuti addirittura in carceri comuni (Silove et al., 2001).
Per quanto confortevole possa essere il luogo della detenzione, le serrature chiuse, il rumore delle porte delle celle e le uniformi evocano memorie traumatiche potentissime (Burnett, Peel, 2001a).
Anche le procedure a cui viene sottoposto il richiedente asilo (interrogatori ripetuti, spesso con un atteggiamento investigativo, di sfiducia nei suoi confronti) possono ripetere qualcosa di già vissuto, se ha subito detenzioni e interrogatori di polizia. Non va dimenticato che questi fatti si verificano in una situazione emotiva difficile, perché l'iter della richiesta di asilo politico è talora lungo e caratterizzato dal continuo terrore di essere rinviati nel paese d'origine (Sinnerbrink et al., 1997).
Considerazioni analoghe valgono anche per procedure apparentemente innocue, come una visita medica: esporre il proprio corpo nudo in mezzo a persone vestite, essere manipolato da estranei può scatenare crisi d'ansia improvvise nelle vittime di tortura.
La mancanza di consapevolezza del rischio di ritraumatizzazione può portare al paradosso di interventi socio-riabilitativi non ben calibrati che conseguono effetti opposti a quelli sperati: recentemente un rifugiato seguito dal nostro servizio ha ottenuto una borsa-lavoro (programma di reinserimento lavorativo agevolato) in una cooperativa dove è stato adibito a lavori di manutenzione di un cimitero. Tra le sue mansioni c'era la riesumazione di resti per ricollocarli in sepolture più piccole. Era fuggito dal suo paese in guerra e sognava cadaveri quasi tutte le notti. Un lavoro del genere ottenne essenzialmente il risultato di aggravarne la sintomatologia.
La ripetizione dei traumi, dovuta al contesto deculturizzante, all'isolamento, alla minaccia di un rimpatrio forzato, e agli stimoli evocativi di un passato terrificante, come quelli che abbiamo descritto, aumenta il rischio di disturbi mentali severi che inficiano le capacità di adattamento nei paesi ospiti e possono avere effetti disabilitanti a lungo termine.
Strategie di intervento
Delineo qui strategie di accoglienza e di intervento specificatamente pensate per interventi di rete psico-sociali, basate su presupposti psicoterapeutici benché in larga parte messe in atto da diverse figure di operatori sociali.
Le strategie sono riassunte nella Figura 4.
| Strategie di intervento
* Scelta/preparazione del personale di accoglienza
* Luoghi di accoglienza adeguati
* Procedure per la concessione dell'asilo
- chiare, comprensibili, accessibili e rapide
- commissioni preparate sui problemi psichici dei richiedenti asilo
- audizioni accompagnate
- ricongiungimenti familiari agevolati
* Organizzazione di servizi specifici
- promozione della socializzazione
- sorveglianza sulle condizioni psichiche
* Costruzione di reti di servizi
* Interventi di protezione dell'identità culturale
* Offerta psicoterapeutica specializzata
Figura 4
Strategie di intervento per l'accoglienza e la riabilitazione dei rifugiati
|
Come si vede, le strategie di igiene mentale dipendono solo in parte dal personale psichiatrico, e molto di più sono legate a interventi sociali adeguati. Consideriamo qui di seguito gli specifici punti:
- Personale di accoglienza. é utile che il personale che opera nella prima accoglienza sia civile, evitando l'impiego di forze militari o di polizia; anche se queste ultime fossero (come a volte sono) ben addestrate al compito, la loro stessa immagine può costituirsi come stimolo scatenante crisi d'ansia, come si è detto, soprattutto in pazienti con PTSD.
Il personale deve essere efficacemente formato, per gestire gli stimoli relazionali complessi che provengono dai richiedenti asilo. Ad esempio, crisi disforiche improvvise o contraddizioni nei racconti delle loro vicende non sono necessariamente segno di personalità aggressive o di tentativi di mentire, ma possono essere sintomi di specifica sofferenza psichica. A tutti dev'essere offerto attivamente un counselling in grado di operare uno screening dei soggetti a rischio psicopatologico. L'offerta attiva è fondamentale, perché la rinuncia a chiedere aiuto fa parte dei quadri clinici che abbiamo descritto e delle corrispettive decisioni di copione.
Va anche attivamente offerta un'assistenza medica con personale specificatamente formato sul piano relazionale: come si è detto in precedenza, visitare un sopravvissuto a torture comporta rischi e richiede cautele particolari, sia dal punto di vista dell'assistito che da quello dell'operatore, esposto al rischio di traumatizzazione secondaria.
- Luoghi di accoglienza: oltre a possedere i requisiti igienici base, devono essere luoghi tranquilli, dove sia possibile avere spazi riservati, e dove il riposo sia facilitato. é esperienza comune di noi clinici quella di incontrare pazienti sofferenti per privazione del sonno: l'arousal aumentato determina continui risvegli o crisi d'ansia, durante la notte, se i richiedenti asilo sono costretti a vivere in ambienti sovraffollati, in cui stimoli rumorosi (persone che entrano e escono dalla stanza, porte che sbattono) sono ripetuti; è questa una situazione comune nelle case d'accoglienza nel nostro paese, dove spesso è proibita anche la permanenza nelle ore diurne. Questi soggetti hanno bisogno di vivere in un ambiente che abbiano l'impressione di poter controllare. Ovviamente centri di pseudo-reclusione o carceri vanno evitati.
- I paesi d'asilo devono impegnarsi a disegnare procedure chiare, comprensibili, facilmente accessibili e soprattutto rapide per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il personale delle commissioni che decidono sulla concessione dell'asilo dev'essere addestrato in modo da comprendere le difficoltà del richiedente nel raccontare la sua storia: anche qui, le possibili contraddizioni di un racconto possono essere segno del disorientamento temporale di cui soffrono alcune vittime di violenza, e non di menzogne. Nella nostra esperienza abbiamo incontrato richiedenti asilo, vittime di tortura particolarmente sofferenti, che si sono visti negare lo status di rifugiato perché incapaci di ricostruire con precisione la loro storia.
Dev'essere concesso ai richiedenti asilo di deporre davanti alle commissioni in compagnia di una persona di fiducia. Il peso dell'interrogatorio ne viene alleviato, perché le somiglianze con interrogatori di polizia senza tutele legali vengono ridotte, è rinforzato il senso di sostegno sociale.
Le pratiche per eventuali ricongiungimenti familiari devono seguire percorsi privilegiati in grado di renderle il più rapido possibile.
Ai richiedenti asilo dev'essere fornita, fin dall'inizio dell'iter burocratico, l'informazione riguardo all'opportunità di farsi accompagnare da certificazioni mediche o psichiatriche al momento dell'audizione presso le commissioni, e alle modalità per ottenerle.
- Servizi specifici. I programmi per l'assistenza ai rifugiati devono prevedere personale sociale e sanitario specificatamente formato e i servizi devono essere forniti con modalità attive, per le ragioni già dette.
Il primo obiettivo di questi servizi dev'essere quello di promuovere una socializzazione protetta per il rifugiato. Può essere raggiunto con modalità differenti: gruppi di discussione che abbiano lo scopo di aiutare la persona a dare un senso alle esperienze passate, attività di gruppo come l'arteterapia, corsi di lingua tenuti da personale capace di comprendere le difficoltà di apprendimento, spesso presenti a causa della sofferenza psichica. In tutte queste attività è necessario informare continuamente il rifugiato del fatto che le sue eventuali difficoltà sono reazioni normali ad esperienze anormali, e non segno di sue debolezze.
é necessaria una sorveglianza continua delle condizioni di salute psichica dei rifugiati in modo da indirizzare con la massima tempestività possibile le persone che ne hanno bisogno alle cure specialistiche.
- Creazione di reti di servizi. Il rifugiato ha spesso necessità di molti servizi diversi: assistenza medica, psicologica, sociale, legale, corsi di istruzione, accompagnamento al lavoro, ricerca di un'abitazione. é necessario che i servizi che se ne occupano siano costituiti in una rete in grado di agevolare i percorsi: oltre ai risultati pratici che questo comporta, vi è anche un vantaggio ulteriore per la salute psichica, perché una rete di questo tipo, composta da personale preparato, contribuisce a rompere l'isolamento sociale del rifugiato. La soluzione ottimale è che ci sia una figura professionale di riferimento (assistente sociale o altro) in grado di fare da ponte tra i vari servizi e che accompagni la persona lungo i suoi percorsi.
- Protezione dell'identità culturale. Quando le condizioni sociali e politiche del paese ospite e di quello di origine e le condizioni di salute dell'individuo lo consentono, è utile promuovere occasioni di incontro tra connazionali, con lo scopo di rafforzare o ricostruire un senso di appartenenza comunitaria. Feste, attività culturali, preferibilmente a gruppi non troppo numerosi, magari con il sostegno dei paesi di origine se mutate condizioni politiche lo consentono, possono fornire aiuti preziosi, soprattutto in previsione di un possibile rimpatrio.
- Offerta psicoterapeutica specializzata. L'offerta di assistenza psicoterapeutica necessita non solo di specialisti esperti in campo psicotraumatologico, ma anche di persone con competenze specifiche nel settore della violenza intenzionale. Trattare una vittima di torture è diverso dalla riabilitazione di una persona dopo un incidente stradale o un terremoto (Herman, 1997). L'intenzionalità dell'atto, come abbiamo visto, ha conseguenze specifiche sia sulla psicodinamica della sofferenza che sul complesso del quadro clinico e richiede interventi mirati, che tengano conto, tra l'altro, in particolare delle dinamiche di introiezione dell'aggressore (Stuthridge, 2006; Sironi, 1999).
Conclusioni
L'approccio alla migrazione come a un evento traumatico consente, ragionando in termini di resilienza e di vulnerabilità, di offrire strategie per la gestione clinica e psico-sociale dei pazienti stranieri.
Esso ci fornisce in particolare un modello per comprendere le modalità di ritraumatizzazione dei rifugiati nella terra d'asilo e quindi per progettare specifici interventi di tutela. La gestione di questi pazienti, spesso gravemente traumatizzati dai precedenti eventi della loro vita, date le peculiarità della loro condizione e della rilevanza della componente sociale nel loro adattamento alla nuova realtà, mira a costruire reti integrate di aiuto psico-sociale.
Per questa ragione, l'Analisi Transazionale in questi contesti si offre come strumento prezioso non solo come teoria della personalità, della psicopatologia e come psicoterapia, ma anche come utile teoria delle organizzazioni.
L'assistenza integrata a pazienti immigrati e psicotraumatizzati, clinica e sociale, si è rivelata utile ed efficace, e consente di curare persone che fino a non molti anni fa sembravano incurabili. Inoltre può costituire un esempio di intervento complesso che può verosimilmente essere esteso ad altri campi della sofferenza psichica, costituendo un modello promettente di psichiatria sociale.
Bibliografia
ALLEN J.R., BENNET S., KEARNS L., Psychological mindedness. A neglected developmental line in permission to think, in «Transactional Analysis Journal», 34, 1, 2004, pp. 3-9.
ALLEN J.R. (2006), trad. it. Oklahoma City dieci anni dopo: psicologia positiva e trasformazione psicosociale del trauma a seguito di un attacco terroristico, in «Quaderni di Psicologia, Analisi Transazionale e Scienze Umane», n. 49, Milano 2008.
BESLIJA A., Psychotherapy with refugees from Bosnia-Herzegovina, in «Transactional Analysis Journal», 27, 1, 1997, pp. 49-54.
BERNE E.(1972), trad.it. Ciao!Ée poi?, Bompiani, Milano 1979.
BHUGRA D., Migration and depression, in «Acta Psychiatr Scand», 108 (suppl. 418), 2003, pp. 67-72.
BHUGRA D., Migration and mental health, in «Acta Psychiatr Scand », 109, 2004, pp. 243-58.
BURNETT A., PEEL M., Asylum seekers and refugees in Britain. The health of survivors of torture and organised violence, in «BMJ», 322, 2001a, pp. 606-9.
BURNETT A., PEEL M., Asylum seekers and refugees in Britain. What brings asylum seekers to the United Kingdom?, in «BMJ», 322, 2001b, pp. 485-8.
CARDOZO B.L., VERGARA A., AGANI F., GOTWAY C.A., Mental health, social functioning, and, attitudes of Kosovar Albanians following the war in Kosovo, in «JAMA», 284, 2000, pp. 56977.
CARITAS, Immigrazione. Dossier Statistico 2007, Idos, Roma 2007.
CORNELL, W. F. (1988) trad. it. La teoria del copione di vita, una rassegna critica in un'ottica evolutiva, in «Neopsiche», 9, 15, 1991.
CHEUNG P., Post-traumatic stress disorder among Cambodian refugees in New Zealand, in «Int. J. Soc. Psychiatry»; 40, 1994, pp. 1726.
CHUNG R.C., KAGAWA-SINGER M., Predictors of psychological distress among Southeast Asian refugees, in «Soc. Sci. Med.», 36, 1993, pp. 6319.
CONNELLY J, SCHWEIGER M., The health risks of the UK's new Asylum Act., in «BMJ» 321, 2000, pp. 56.
DEVOTO G., OLI G.C., Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1990.
ERSKINE R.G., ZALCMAN M.J. (1979), trad it. Sistema Ricatto: un modello per l'analisi del ricatto, in «Neopsiche», n. 5, 1985.
FRIGHI L., PIAZZI A., MAZZETTI M., Caratteristiche Socio-Demografiche, Salute Psichica e Fattori di Rischio Psicopatologico dell'Immigrazione Extra-Comunitaria a Roma, in «Difesa Sociale», vol. LXXII, n° 5, 1993, pp. 183-200.
FONAGY P., STEELE M., STEELE H., HIGGIT A., The Emanuel Miller memorial lecture 1992: The theory and practice of resilience, in «Journal of Child Psychology and Psychiatry», 35, 2, 1994, pp. 231-57.
GORSTUNSWORTH C, GOLDENBERG E., Psychological sequelae of torture and organised violence suffered by refugees from Iraq. Traumarelated factors compared to social factors in exile, in «Br J Psychiatry», 172, 1998, pp. 904.
HERMAN J. L. (1997), trad. it. Guarire dal trauma, Edizioni Magi, Roma 2005.
KOSER K., Irregular Migration, State Security and Human Security: A Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Programm of the Global Commission on International Migration, Global Commission on International Migration, Ginevra 2005.
LEVENSON R, COKER N., The health of refugees, King's Fund, London 1999.
LEVI P., Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1947.
MAIN M., KAPLAN N., CASSIDY J., Security in infancy, childhood and adulthood: A move to the level of representation, in I. Bretherton, E. Waters, Growing points of attachment theory and research, in «Monographs of the Society for Research in Child Development», 50, 1-2, serie 209, 1985.
MASSE V., The Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder Using Redecision Therapy, in «Transactional Analysis Journal», 25, 4, 1995, pp. 356-60.
MAZZETTI M., Strappare le radici. Psicologia e psicopatologia di donne e di uomini che migrano, L'Harmattan Italia, Torino 1996.
MAZZETTI M., A Transactional Analysis Approach to Adjustement Problems of Adolescents from Immigrant Families, in «Transactional Analysis Journal», 27, 3, 1997 pp. 220-23.
MAZZETTI M., Passio exilii: rifugiati e salute psichica. Prima parte: il trauma, in «Quaderni di Psicologia, Analisi Transazionale e Scienze Umane, n. 27-28, 1999, pp. 133-57.
MAZZETTI M., Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto, Carocci, Roma 2003.
MAZZETTI M., Cultural Identities in Movement in a World in Movement: New Frontiers for Transactional Analisys, EATA Newsletter, 90, pp. 6-13.
MOLLICA R.F., DONELAN K., TOR S. et al., The effect of trauma and confinement on functional health and mental health status of Cambodians living in Thailand-Cambodia border camps, in «JAMA», 270, pp. 58186.
MOLLICA R.F., MC.INNES K., POOL C., TOR S., Dose effect relationships of trauma to symptoms of depression and post-traumatic stress disorder among Cambodian survivors of mass violence, in «Br J Psychiatry», 173, 1998, pp. 48288.
MOLLICA R.F, MCINNES K., PHAM T., SMITH FAWZI M.C., MURPHY E., LIN L., The dose-effect relationships between torture and psychiatric symptoms in Vietnamese ex-political detainees and a comparison group, in «J Nerv Ment Dis.», 186, 1998, pp. 54353.
MOLLICA R.F., MC.INNES K., SARAJLIC N., LAVELLE J., SARAJLIC I., MASSAGLI M.P., Disability associated with psychiatric comorbidity and health status in Bosnian refugees living in Croatia, in «JAMA», 282, 1999, pp. 43339.
PENNAC, D. (1990), trad. it., La prosivendola, Feltrinelli Editore, Milano 1993.
SCHAFFER, R.H., (1996) trad. it., Lo Sviluppo Sociale, Cortina Editore, Milano1998.
SINNERBRINK I., SILOVE D., FIELD A., STEEL Z., MANICAVASAGAR V., Compounding of premigration trauma and postmigration stress in asylum seekers, in «J Psychol»,131, 1997, pp. 46370.
SILOVE D., STEEL Z., MOLLICA R., Detention of asylum seekers: assault on health, human rights, and social development, in «Lancet», 357, 2001, pp. 1436-37.
SIRONI F. (1999), trad. it. Persecutori e vittime, Feltrinelli, Milano 2001.
STEEL Z., SILOVE D., PHAN T., BAUMAN A., Long-term effect of psychological trauma on the mental health of Vietnamese refugees resettled in Australia: a population-based study, in «Lancet», 360, 2002, pp. 1056-62.
STEINER C. (1966) trad. it. Copione e Controcopione, in «Rivista Italiana di AT e Metodologie Psicoterapeutiche», I, 1, 1981.
STUTHRIDGE J. (2006), trad. it. Il dentro messo fuori:un modello analitico transazionale del trauma, in «Quaderni di Psicologia, Analisi Transazionale e Scienze umane», n. 49, Milano 2008.
TEDESCHI R.G., CALHOUN L.G., The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma, in «Journal of Traumatic Stress», 9, 3, 1996, pp. 455-72.
TURNER S., GORST-UNSWORTH C., The psychological sequelae of torture: a descriptive model, in «Br J Psychiatry», 157, 1990, pp. 475-80.
TURNER S.W., BOWIE C., DUNN G., SHAPO L., YULE W., Mental health of kosovan albanian refugees in the UK, in «Br J Psychiatry»,182, 2003, pp. 444-48.
UNFPA, Lo stato della popolazione nel mondo, UNFPA, Roma 2006.
UNHCR, 2006 Global Trends: Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, UNHCR, New York 2007a.
UNHCR, (2007b), Richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia, in Caritas, Immigrazione. Dossier Statistico 2007, Idos, Roma 2007.
UNITED NATIONS, World Population Monitoring. Focusing on International Migration and Development: Report of Secretary-General. New York, United Nations, 2006.
VAN DER KOLK B.A. (1996), trad. it. Trauma e memoria, in B.A. Van der Kolk, A.C. McFarlane, L. Weisaeth, Stress traumatico, Edizioni Magi, Roma 2004.
VANVELSEN C., GORST-UNSWORTH C., TURNER S.W., Survivors of torture and organized violence: demography and diagnosis, in «Journal of Traumatic Stress», 9, 1996, pp.181-93.
VICTORIAN FOUNDATION FOR SURVIVORS OF TORTURE, Refugee health and general practice, Melbourne Printing Professionals, Melbourne 1998.
Nota:
Marco Mazzetti, psichiatra, analista transazionale didatta e supervisore in psicoterapia, TSTA-P dell'EATA (European Association for Transactional Analysis), docente universitario. Svolge la sua attivit clinica, didattica e di ricerca presso il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e il Servizio di Etnopsichiatria Terrenuove di Milano, Italia. é presidente della Commissione di Certificazione (COC) dell'EATA
e-mail: marcomazzetti.at@libero.it
|